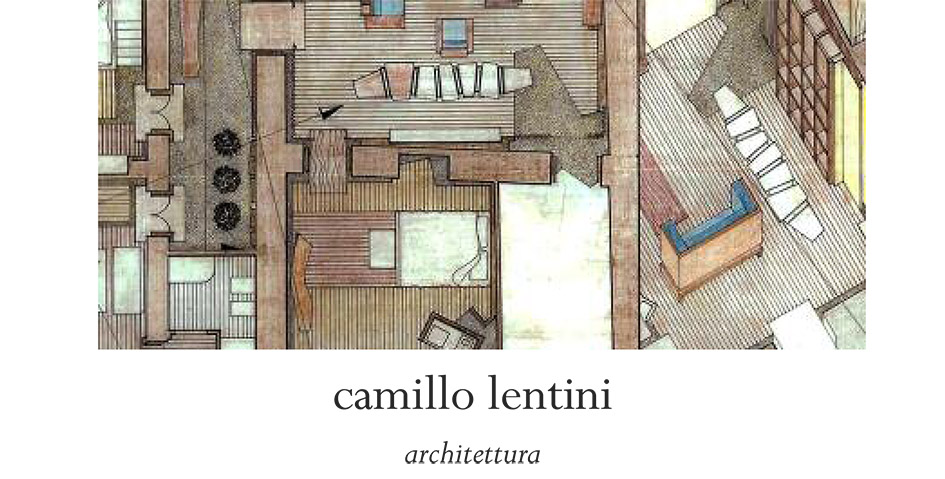Mostrarle dei tentativi? Ahimé, benché già vecchio, sono ancora agli inizi. Tuttavia comincio a capire, se così si può dire, io comincio a capire… (Cézanne)
Un discorso sull’abitare non può prescindere da
un discorso sull’essere.
Il concetto di essere è im-mediatamente (cioè senza alcuna mediazione
possibile) legato al concetto di tempo, nel senso che è l’Essere che nel
momento in cui pone se stesso istituisce il tempo. Quello suo, e quello degli
enti con i quali entra in relazione.
Ma questa è anche la sua condanna: non potere esistere al di fuori del tempo
che esso stesso è in quanto da se stesso posto con la sua apparizione. Perché
essendo fuori dal tempo l’Essere è Tutto, mentre essendo nel tempo l’Essere di Tutto
si è privato. Se ne è privato per necessità, cioè è stato necessario perdere Tutto
per essere Sé, soggetto, individuo.
A questo punto si pone una scelta: che anch’essa si presenta quasi sempre nei termini di una necessità, e dunque di non-scelta: continuare sulla strada che va sempre avanti e tutto lascia indietro, dimenticandolo – che sarebbe anche atto di coerenza; oppure scegliere una strada che andando avanti torna indietro, cioè che procede in senso circolare, avvolgendosi in una spirale. Laddove il tornare indietro non è vezzo, né una via di fuga, ma una semplice necessità fisiologica: perché la permanenza del passato esige un suo continuo ri-esperimento, cioè un continuo ri-farne esperienza.
La permanenza del passato è funzionale, a quest’Essere che di Tutto si è privato, perché questa è l’unica sua possibilità per Tutto tenere insieme: in qualche modo. Perché tenere insieme Tutto significa Essere Tutto nello stesso momento. Ma dire Essere Tutto è come dire Nero Bianco, perché, come abbiamo visto, o si è Essere o si è Tutto. Tenere insieme tutto nel senso proprio quindi non è nelle possibilità dei mortali. Ma tenerlo insieme col lavoro di una vita: questo sì.
Perché la permanenza del passato ha a che fare con la poesia? Per un aspetto formale e per un aspetto sostanziale. Per un aspetto formale in quanto al contenuto, perché l’argomento di cui si parla nelle poesie è il passato; per un aspetto sostanziale a causa della sua stessa natura, che non è quella del fare, da poiesis, come sempre è stato detto, ma è quella del tornare, del volgersi, dell’andare a capo: da versus, vertere.
Nel verso infatti, attraverso la cadenza degli accenti, si stabilisce un ritmo per mezzo e per causa del quale il tempo torna dove era partito. Nel senso che per la sapiente composizione degli accenti il verso si interrompe dove è necessario che si interrompa costringendo il tempo ad andare a capo, cioè a tornare indietro, istituendo in questo modo una progressione circolare. Questa continua ripetizione di vuoti e pieni, di interruzioni e di ripartenze, ordinate secondo una regola musicale, produce un ritmo che distoglie il sentire dall’ordinaria continuità uniforme del pensare, cioè del presente. L’effetto prodotto da questo ritmo è una versione addomesticata, ma ancora efficace, del rito dionisiaco per mezzo del quale gli adepti uscivano da se stessi per tornare – per riunirsi – al Tutto. Non si tratta dunque solo di dire cose che richiamano o riguardano eventi passati, né di usare parole ad effetto: attraverso l’esecuzione del verso il tempo, tornando dove era partito, tiene insieme tutto quello che nel suo farsi è avvenuto. Quesa naturalmente è l’essenza della musica.
Questo tempo ciclico, cioè questo tempo che per andare avanti torna indietro, è l’Eterno Ritorno, che non è il banale ritorno del passato, ma il ritorno dei pensieri e dei sentimenti – cioè di tutto il sentito – del passato, e non è neanche un ritorno, perché i pensieri e il sentito del passato non sono mai andati via; in questo senso la permanenza del passato non si manifesta attraverso un documento, un fatto culturale, una parola scritta – ma è un’esperienza ri-vissuta.
Questo è quello che voleva dire Holderlin, quando diceva che poeticamente abita l’uomo: e cioè che l’uomo, l’Essere, abita solo in un tempo ciclico: può abitare solo un tempo in cui tutto (sottoforma di pensieri e sentimenti) non passa ma permane. Per questo il senso dell’abitare può essere solo poetico: cioè abitare poeticamente significa darsi le condizioni per permanere nel tempo ciclico, il tempo che va avanti tornando indietro, che è il tempo dell’essere nella sua natura, perché la natura dell’Essere è di desiderare di tornare da dove era venuto, cioè dal Tutto.
In questo senso abitare poeticamente non necessariamente ha a che fare con l’architettura, ma necessariamente con la storia: cioè con il racconto di sé che ognuno fa a se stesso. Ognuno di noi infatti, dal momento in cui inconsapevolmente si costituisce come soggetto, comincia a costruire la propria casa interiore, che è l’unico vero luogo in cui il soggetto vive, indipendentemente dal luogo fisico in cui materialmente si trova.
Abitare poeticamente dunque significa acquisire questa consapevolezza, cioè significa avere coscienza di essere una casa.
Cosa non scontata e per nulla facile. La costruzione di questa casa infatti comincia con l’apparizione dell’Essere e termina solo con la sua morte. Alla sua costruzione inoltre partecipano innumerevoli attori, interiori ed esteriori, e cioè solo necessariamente interiori, direbbero alcuni, o esteriori interiormente determinati, come direbbero altri; con i quali si può entrare in relazione per via casuale, come dicono alcuni, o facendo in modo che succeda casualmente, come dicono altri. Resta il fatto, comunque la si voglia pensare, che si tratta di un lavoro, aggravato da mille difficoltà, che riguarda solamente il soggetto. Di questo lavoro la casa è la scena.
Ogni casa infatti dovrebbe, per la sua conformazione (spazi fisici dedicati all’inutile, cioè metriquadri non redditizi, oggi inconcepibili), e per la sua permeabilità (permanenza delle storie nelle incrostazioni dell’intonaco e nei graffi del pavimento, oggi inconcepibili), consentire quella stratificazione dei giorni nel loro trascorrere che, essendo appunto visibile nel presente sotto forma di trasformazione (ingiallimento, invecchiamento) della materia, conferisce al presente stesso una diversa consistenza, trasformandolo in quella dimensione del reale che non è statico e vuoto permanere ma parvenza di altro, che è stato o che sarà, e che appunto attraverso quella parvenza permane o viene preannunziato. Trasformando cioè il presente nella permanenza di ciò che solo apparentemente è passato e nell’attesa di ciò sta per giungere.
Bisogna cioè che la casa abbia la possibilità di invecchiare, e questo non è più possibile, non solo perché non ne esistono più le necessarie condizioni culturali (tutto sia nuovo, lucido e pulito: questa è l’etica del modernismo: sostituire prima che invecchi); ma anche perché nel modello sociale della modernità conformato sulle esigenze del modello produttivo (cioè le nuove condizioni culturali) non esiste più la casa, ma esistono solo alloggi, come già nel 1945 Adorno aveva scritto, e vengono i brividi a pensare a quanto oltre, rispetto ad allora, siamo andati.
E non esiste più la casa semplicemente perché non può esistere più la famiglia, ovverossia quell’organismo sociale che può nascere solo per conseguenza (e in virtù) della possibilità (cioè dell’opportunità, ai fini economici) per un nucleo di persone di permanere stabilmente in un luogo. La differenza tra economia locale ed economia globale è tutta qui, e le conseguenze che questo passaggio comporta sono tali da interessare i processi evolutivi, cioè sono in grado di cambiare la natura dell’uomo.
L’abitare poetico, e quindi la possibilità di esperire il tempo reale dell’essere, non è più possibile appunto perché non è più possibile l’abitare, che etimologicamente significa avere un habitus, cioè un abitudine, cioè una abitazione, che è la condizione in cui si ha un’abitudine: un darsi le condizioni per cui si manifesti una abitudine: un avere frequentazione di sé: dunque un “avere se stessi”. Cioè non si può essere pienamente, dunque essere sè nella sua pienezza, se non si può avere se stessi.
La lingua esprime con cruda immediatezza quello che appariva confuso ma che ora è del tutto evidente. Perché se non si può avere se stessi non si è di se stessi, ma di qualcun altro. Dunque schiavi.